La storia più apprezzata della settimana è “Non sei più tu” di Giovanna Brunitto, pubblicata sul n. 44 di Confidenze.
Sul blog di CONFIDENZE – Storia vera di Paola F.
“Potete dar loro il vostro amore, ma non le vostre idee” con queste parole il poeta Gibran descrive cosa un genitore può dare ai propri figli e ogni volta che ci penso il mio cuore si fa pesante e mi chiedo cosa abbia dato io a mio figlio. La risposta a oggi non la so dare, non vedo Alberto da mesi. Ma andiamo con ordine. Mio figlio è arrivato che avevo appena finito l’Università, avevo 25 anni. Ci siamo sposati in fretta io e Nicola e, per quel bimbo in arrivo, avremmo fatto qualsiasi cosa. Nicola aveva appena iniziato a lavorare come commercialista in uno studio e lo stipendio era modesto, ma ce l’abbiamo fatta con tanto amore e tanti sacrifici. Dopo qualche anno, avevamo uno studio nostro, una bella casa e un bambino che adoravamo e viziavamo. Niente era mai troppo per il nostro Alberto. Vacanze e soggiorni all’estero d’estate, settimana bianca in inverno e scuole private per dargli un’educazione che fosse la migliore possibile. Alberto non è mai stato portato per gli studi ma con diversi aiuti e ripetizioni varie, alla fine si è diplomato. L’adolescenza è stata per nostro figlio un periodo di indolenza e, nonostante i mille stimoli che gli proponessimo, niente sembrava interessarlo per davvero. Aveva qualche amico e aveva avuto anche qualche ragazzina, ma se restava solo non se ne faceva un problema. Si chiudeva nella sua camera per interi pomeriggi a fare niente. Io e Nicola lo osservavamo preoccupati, ma studiava quanto basta, era tranquillo e non ci dava particolari problemi, quindi non potevamo dirgli niente se non di avere più interessi, di praticare qualche sport, di uscire un po’ di più. Avremmo fatto qualsiasi cosa per quel ragazzino, per vederlo contento, ma lui era solitario e parlava poco con noi, non sapevamo niente di cosa pensasse o di come si sentisse, e poi, in fondo pensavamo che tutti i giovani sono così a quell’età.
Finito il liceo, gli abbiamo regalato un viaggio negli Usa promesso da anni; ci sembrava un inizio importante per la vita da adulto, gli sarebbe servito per staccarsi un po’ dal nido e rendersi più indipendente anche nelle cose quotidiane. Questo è quello che ci dicevamo per rassicurarci, vedere Alberto partire da solo ci faceva paura, ma dovevamo accettare che stesse diventando adulto. Al ritorno avrebbe dovuto iniziare la facoltà di Giurisprudenza, scelta da lui. Ad agosto, dopo un mese che era via, chiamò per dirci che non sarebbe tornato subito ma avrebbe prolungato il viaggio di qualche settimana. Era a Long Beach in California e aveva conosciuto dei ragazzi che si allenavano sulla spiaggia per dei campionati di culturismo, voleva restare fino a settembre per assistere alla gara. Io e mio marito eravamo contenti di sentirlo entusiasta e anche meravigliati perché, fino a quel momento, non si era mai interessato di sport e cura dei muscoli.
A quella telefonata ne seguirono altre e le richieste erano sempre le stesse, soldi e altro tempo per stare negli Stati Uniti. L’iscrizione all’Università nel frattempo era saltata. La contentezza mia e di mio marito svanì presto, continuavamo a chiederci cosa stesse succedendo e se avessimo fatto bene a mandarlo così lontano da solo. Alberto al telefono ci parlava di palestre, di ragazze, di cantanti e musica rap. Non capivamo i suoi interessi ed eravamo molto preoccupati, ma ci dicevamo che se questo era il suo desiderio, l’avremmo assecondato, perché quello che ci è sempre stato a cuore più di ogni altra cosa al mondo è la felicità di nostro figlio. Digerire che non andasse all’Università non è stato semplice per me che già lo immaginavo avvocato di grido in tutti i tribunali italiani, ma pian piano mi sono abituata all’idea. Forse, pensavo tra me e me, quando torna in Italia approfondirà l’esperienza americana e proseguirà gli studi di Educazione Fisica, magari potrebbe diventare insegnante. Cercavo di calmarmi da un’ansia subdola che mi divorava e che a stento placavo. Avevo sempre riso di quelle mamme che sono costantemente preoccupate per i figli e adesso ero diventata una di loro. Poco prima di Natale, Alberto rientrò in Italia e il mio ragazzino emaciato e scontroso era scomparso per dare spazio a un giovane uomo abbronzato e muscoloso. Nel giro di qualche mese era cambiato nel fisico ma anche nei pensieri. Aveva idee estremiste che erano lontane ed estranee alla nostra famiglia. Ce l’aveva con gli immigrati e con le tasse esose che secondo lui non dovevano essere pagate. Io e Nicola, all’inizio, lo prendevamo in giro perché gli dicevamo che se fosse stato così noi, essendo commercialisti, saremmo rimasti senza lavoro, ma Alberto sembrava non cogliere l’ironia e continuava con le sue invettive. E poi è iniziato il valzer delle ragazze. Una dopo l’altra, consumate come caramelle, tutte appariscenti e vuote, tutte uguali. Ero atterrita dalla nuova vita che Alberto portava avanti. Avevo la sensazione di perderlo a piccoli pezzi, ogni giorno di più. Non ci assomigliava e non aveva neanche voglia di assomigliarci. Era diverso, ma in una maniera per me inaccettabile. Non mi piacciono le persone che hanno idee estremiste, non mi piacciono i razzisti, non mi piacciono quelli che buttano via le giornate senza impegni come se il futuro non fosse da costruire, non mi piacciono gli uomini che trattano le donne come oggetti da consumare. E mio figlio era una di queste persone. Ero lacerata dal dolore. Volevo scuoterlo, volevo tirarlo via da questo limbo dov’era ma non sapevo come fare. Ogni volta che intavolavamo un discorso, finiva con urla e litigi. E se provavo a parlarci da sola, era pure peggio. Alberto mi diceva che si vedeva lontano un miglio che non approvavo le sue scelte, ma a lui andava bene così. Sbatteva qualcosa e se ne andava. Qualche mese dopo, ha trovato lavoro in una palestra e le cose si sono assestate. Le ragazze erano sempre tante e le sue idee sempre estreme, ma in casa era più tranquillo e con il passare del tempo anch’io e Nicola ci siamo calmati. Poi, come una giornata di sole dopo un lungo inverno piovoso, è arrivata Morena. Ce l’ha presentata una domenica pomeriggio. Morena è una ragazza incantevole, e non solo perché è molto carina, ma per il suo carattere determinato e dolce, forte e sensibile allo stesso tempo. Alberto l’ha conosciuta in una delle palestre dove lavorava e si sono fidanzati dopo pochi mesi. Morena mi è piaciuta sin da subito. È orfana di entrambi i genitori, mancati in un incidente quando lei era ancora una bambina, eppure è come se i suoi li portasse dentro. Li nomina spesso e sento molte volte che cita a esempio gli insegnamenti che le hanno lasciato i suoi genitori. È cresciuta con la nonna materna e seppure deve essere stata molto sola, è una ragazza solare e sorridente che ama la vita, sempre buona e gentile verso tutti. È difficile non volerle bene. Ecco, se avessi avuto una figlia femmina, io l’avrei voluta così, come Morena. Lei e Alberto sono andati a convivere ed è stato bello vedere il loro amore crescere. Alessandro e Gaia, i miei nipoti, sono arrivati nel giro di un paio d’anni e sono quanto di più bello la vita abbia dato a tutti noi. La magia si è rotta circa sei mesi fa, quando Morena mi ha confessato che Alberto la tradisce. L’ha già fatto una volta e lei lo ha perdonato, ma adesso, mi ha detto, non può più farlo perché Alberto deve crescere e imparare che se vuole essere amato, deve prima amare. L’ho abbracciata forte Morena, e mi è apparsa ancora più piccola di quanto in realtà sia. Ho capito cosa diceva e l’ho sentita vicina al mio cuore più che mai. Abbiamo pianto insieme. Ho provato a sentire la versione di Alberto e ho provato a farlo ragionare. Buttare via una famiglia in quel modo era una crudeltà verso i bambini e anche verso se stesso perché nessuno l’avrebbe mai amato come Morena.
Ma Alberto non ha sentito ragioni e urlando mi ha detto che lui aveva il diritto di vivere e che nessuno lo poteva tenere incatenato. La superficialità dei suoi ragionamenti mi ha colpito con la forza di un pugno, dritto alla bocca dello stomaco.
Alberto non ha mai nominato i suoi splendidi bambini, come se neanche gli appartenessero.
Allora ho pianto tutte le mie lacrime. Per il fallimento come madre e soprattutto perché non ho saputo insegnare a mio figlio i valori importanti della vita: la famiglia, l’onestà verso gli altri, la fedeltà, il rispetto degli impegni presi, la perseveranza. E ho preso la decisione più difficile della mia vita. Se Alberto voleva lasciare la sua famiglia non potevo impedirlo, ma io non avrei più voluto vederlo, né parlargli. Non avrei potuto accettare di fargli ancora una volta da paracadute. Io e Nicola abbiamo parlato con Morena e le abbiamo detto che noi ci saremmo sempre stati per i nipotini e per lei. E questo è quello che facciamo da sei mesi: aiutiamo Morena e per la prima volta dopo anni ci sentiamo bene, in pace. Morena ci tratta come due genitori ansiogeni, ci porta Alessandro e Gaia al mattino presto così li accompagniamo a scuola. Poi riprendiamo i bimbi al pomeriggio, prepariamo le merende e li riportiamo da lei. Con lo studio e grazie a degli ottimi collaboratori riusciamo ad avere tempo per i nostri nipotini. La domenica sono a pranzo a casa da noi. Siamo una vera famiglia. Abbiamo detto a Morena che se vorrà, potrà trovare un nuovo compagno, noi la comprenderemo, ma lei ci ha risposto di non pensarci proprio perché i bimbi la tengono già troppo occupata. In fondo so qual è la verità: lei aspetta Alberto, aspetta che torni. E in questo siamo ancora più unite, perché anch’io sono in attesa. Mio figlio farà tanti giri, per lui il sentiero della maturità è più lungo e tortuoso che per altri, ma poi verrà da noi e noi saremo qui ad aspettarlo. Noi siamo la sua famiglia.
{lang: 'it'}







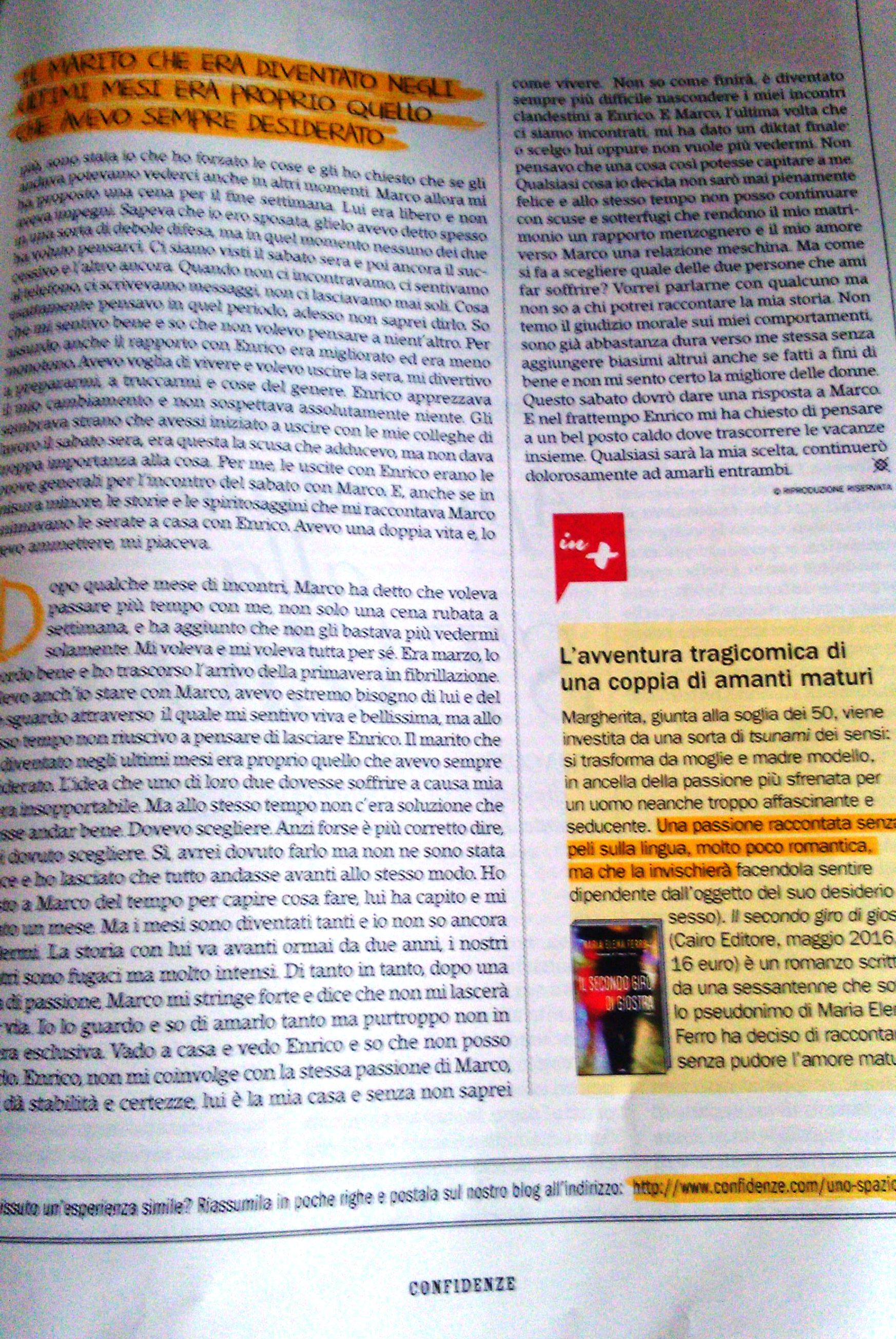
![TimeStamp:2016/07/28 15:20:33.000, Protocol:email, Destination:[giovanna.brunitto@telecomitalia.it]](http://www.giovannabrunitto.it/wp-content/uploads/2016/07/Il-Sugo-della-Domenica-20-Luglio-2016-pag.-1.pdf.jpg)
![TimeStamp:2016/07/28 15:20:33.000, Protocol:email, Destination:[giovanna.brunitto@telecomitalia.it]](http://www.giovannabrunitto.it/wp-content/uploads/2016/07/Il-Sugo-della-Domenica-20-Luglio-2016-pag.-2.pdf.jpg)





